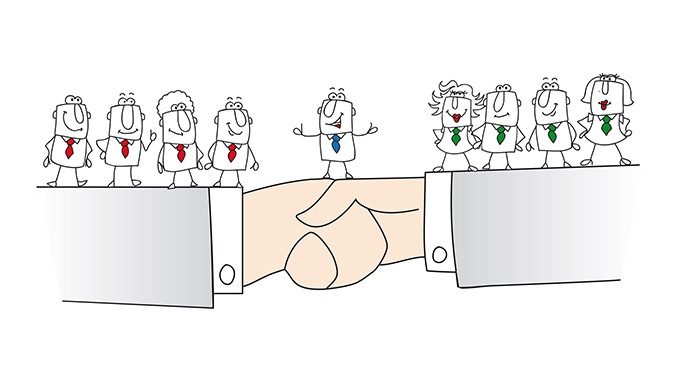«Non si deve negoziare per paura, ma non bisogna mai aver paura di negoziare». A questa frase di John F. Kennedy si ispirava il titolo di un libro che avevo letto nel 2001: Il coraggio di mediare, curato da Fulvio Scaparro, psicoterapeuta, già presidente del Comitato Etico Indipendente dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Il volume costituiva in Italia la prima trattazione sistematica e interdisciplinare del tema della mediazione, attività dalle radici antiche, ma che nasce nel secolo scorso, come tecnica e procedura istituzionalizzata, negli Stati Uniti come soluzione dei conflitti del mondo del lavoro, per poi estendersi all’ambito familiare e ad altre circostanze in cui si sperimentano conflitti sociali e interpersonali (cfr p. 130).
“La mediazione – scrive Scaparro nell’introduzione– non è soltanto una tecnica né soltanto un’utopia. E’ una tecnica fortemente carica di utopia. Richiede al mediatore e alle parti in conflitto coraggio, praticità, pazienza, ma anche la capacità di sognare e desiderare uno scenario diverso che ci vede in lotta” (p.16).
Tutti gli ambiti della nostra esistenza quotidiana – famiglia, lavoro, scuola, spazi pubblici – sono attraversati da conflitti, frutto di relazioni difficoltose, “malate” o profondamente in crisi, in cui l’altro non è incontrato ma utilizzato per fini egoistici. Di fronte a questa realtà Scaparro invita a non temere di aiutare le parti a comunicare : la mediazione si pone come una via per ristabilire il dialogo, cercare soluzioni pacifiche alle dispute, accettare le diversità e risolvere le chiusure, ristabilendo o guarendo le relazioni.
La mediazione appare dunque necessaria per rispondere a un’esigenza del nostro tempo. Per questi motivi Scaparro ritiene fondamentale diffondere una cultura capace di salvaguardare la potenziale fertilità del conflitto e della diversità attraverso la ricerca di soluzioni eque e rispettose delle esigenze degli interessati.
Ci sono varie forme di mediazione, da quella familiare come “giustizia del quotidiano” in grado di spostare l’accento “dalla risoluzione al governo del conflitto” (p. 111) a quelle politiche che si rivolvono con un negoziato e che per Scaparro significa «mantenere giovane la democrazia» (p. 12).
Ad approfondire questo aspetto è il pedagogista Daniele Novara, secondo il quale mancano nella nostra società una corretta «alfabetizzazione al conflitto» e un’«educazione alla pace» (p. 177 ). La mediazione può permettere invece di educare ad una pace matura, che non significa irenismo o totale identità di vedute. Piuttosto – sostiene ancora Novara –– l’educazione alla pace attraverso la mediazione permette di costruire la capacità di stare dentro il conflitto e vivere autentiche relazioni umane nonostante divergenze e resistenze. Sei atteggiamenti positivi vengono presentati come indispensabili per una corretta educazione alla pace: considerare come un problema da gestire e non come una guerra da combattere; “contare fino a dieci” prima di agire per evitare le reazioni impulsive e compulsive; non fare muro contro muro per sdrammatizzare le tensioni evitando il «muro contro muro»; rispettare i contenuti del conflitto; sperimentare la critica costruttiva in una dimensione di ascolto; saper dire di no quando occorre per non conformarsi e assumersi una responsabilità adulta (cfr pp. 184-186).
Tra le varie articolazioni della mediazione presentate nei diversi saggi, merita attenzione in ambito penale la formulazione di una teoria della giustizia particolarmente innovativa: la c.d. «giustizia riparativa» fondata più sul risarcimento alla vittima che sulla punizione del colpevole. A spiegarla è Adolfo Ceretti, professore di criminologia e responsabile dell’Ufficio per la Mediazione di Milano: «Si tratta di un modello d’intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che si avvale non della pena o di alcune delle “sottoarticolazioni” sanzionatorie tradizionali, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e, soprattutto, la riconciliazione tra autore e vittima» (p. 309). A questo modello d’intervento soggiace una vera e propria rivoluzione copernicana nella concezione di giustizia: «Le questioni fondamentali – spiega Ceretti – non sono più “chi merita di essere punito?” e “con quali sanzioni?” bensì “cosa può essere fatto per riparare il danno?”, laddove riparare non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato. Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento e che affonda le proprie radici nel percorso di mediazione che la precede” (p. 310). Nonostante le forti resistenze che il nuovo paradigma suscita in un’epoca in cui le logiche retributive sembra guadagnare nuovo favore, la prospettiva della giustizia riparativa suscita crescente interesse in Europa e in seno all’ONU. L’esperienza dell’Ufficio per la Mediazione di Milano, di cui vengono illustrate le tecniche e le modalità operative concrete, ne dimostra i risultati positivi (cfr pp. 333-352).
La mediazione privilegia vari livelli: anzitutto quello delle relazioni interpersonali, e quindi ai c.d. conflitti di seconda generazione: quelli di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici, interculturali, d’ambiente, sul posto di lavoro (p. 56). Purtroppo, nonostante l’esplosione dei conflitti etnici e le tensioni tra culture, solo l’ultimo capitolo del libro affronta la mediazione a livello macro nei conflitti di “prima generazione”, quelli tra tra gruppi, strati o classi sociali. Abdessalam Najjar, membro fondatore di Nevé Shalom/Wahat al-Salam, unica comunità ebraico-palestinese, approfondisce la tecnica dell’incontro tra due gruppi in contrasto (pp. 401-408).
Quel volume ci ha consegnato due domande acora oggi attuali. La prima riguarda l’interpretazione della mediazione a livello antropologico: è possibile considerarla una sorta di «perdono laico» o secolarizzato? Ma questa espressione non deve trarre in inganno. Non viene negata l’importanza del perdono, quanto piuttosto una sua interpretazione superficiale e «buonista», che sorvola la profonda e paziente elaborazione interiore che esso invece comporta. Solo attraverso questo impegnativo itinerario diventa possibile la riconciliazione dei contendenti, che gratuitamente si donano l’un l’altro, oltre le strettoie del presente conflittuale, una nuova possibilità di futuro. Riconoscimento reciproco, gratuità, progettualità: tutti elementi che risuonano nel termine tedesco «riconciliazione» (Versohnung: ritornare figli), scelto da Scaparro stesso. Un termine che richiama la parabola del padre misericordioso che accoglie il «figlio prodigo» (Luca 15, 11-32), in cui riconciliazione e perdono si danno strettamente associati.
La seconda questione aperta riguarda l’identità o il profilo del mediatore, figura centrale ed insostituibile del processo di mediazione. La definizione che emerge dal volume non è univoca. Alcuni autori concepiscono il mediatore come un terzo neutrale, mentre altri ne delineano il ruolo di figura capace di essere sia una parte sia l’altra, un soggetto equiprossimo alle parti in conflitto(p. 164). Tutti concordano nel non accostare il mediatore a uno psicoterapeuta, un avvocato o un giudice: egli deve limitarsi a favorire la comunicazione in modo che le parti possano superare l’impasse del conflitto, negoziare una soluzione e trovare accordi equi e soddisfacenti per entrambi.
Rimane così aperta la formazione dei futuri mediatori. Scaparro propone scuole di formazione “non tecniciste” che, affidando il ruolo di docenti a persone direttamente impegnate in processi di mediazione, sappiano trasmettere come, cosa e perché mediare (cfr p. 16).
Il volume nel suo complesso ha infine il merito di collocare al centro dell’attenzione ciò di cui abbiamo più bisogno: il rapporto con l’altro. Aprirsi a questa esperienza diventa anche la fonte stessa dell’istanza etica che la società contemporanea sta cercando.
L’esperienze e i risultati presentati nel volume dicono che la mediazione è possibile. Occorre però la volontà di ribadire quanto Socrate afferma nel dialogo platonico Ippia Maggiore: “Credo di aver capito cosa vuol dire il proverbio: le cose belle sono difficili”.